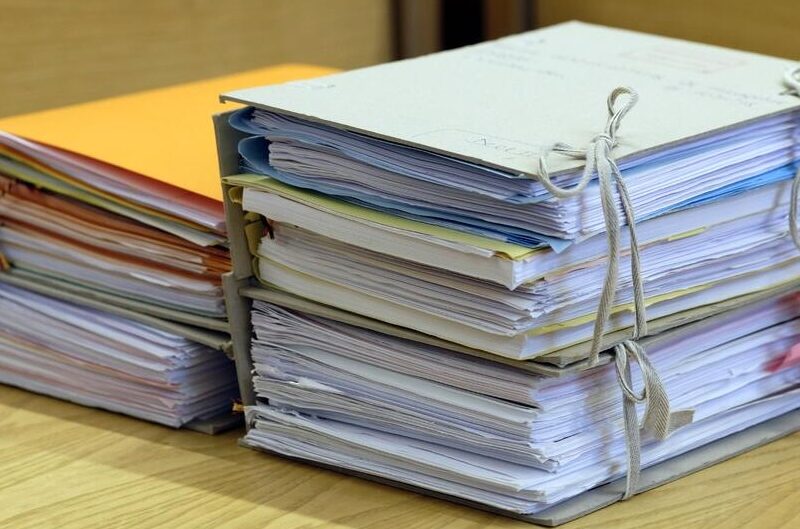L’esigenza di promuovere stili alimentari corretti ha indotto negli ultimi anni molti stati a utilizzare strumenti di carattere fiscale per disincentivare il consumo dei cosiddetti cibi spazzatura (junk food) e favorire l’uso di quelli più salutari. Infatti, l’imposizione di tasse che incrementano il prezzo di vendita di cibi dannosi per la salute (come i cibi grassi e le bibite zuccherate) e la detassazione di cibi sani (ad esempio, molti di quelli rientranti nella dieta mediterranea) può essere una leva capace di orientare le abitudini nutrizionali dei cittadini.
Il documento dell’Oms
Nel giugno scorso, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato un documento programmatico – Fiscal policies to promote healthy diets: policy brief – in tema di politiche fiscali tese a contrastare il consumo degli alimenti più dannosi per la salute a favore di quelli più sani.
Con particolare riguardo alle bevande zuccherate – afferma l’Oms, citando le esperienze di alcuni stati – una maggiore imposizione fiscale è idonea a determinare la riduzione degli acquisti e dei consumi delle bevande tassate; l’aumento degli acquisti e dei consumi di quelle non tassate; la riformulazione del contenuto delle bevande stesse da parte delle imprese produttrici per ridurne i livelli di zucchero; nuove entrate fiscali per lo stato. Le prove dei benefici sono più limitate, invece, relativamente alla tassazione di altri alimenti reputati dannosi per la salute.
Secondo l’Oms, l’attuazione di politiche fiscali per promuovere diete sane – sia attraverso nuove tasse o sovvenzioni, sia attraverso l’aumento dell’aliquota di tasse esistenti – deve rispettare alcune condizioni. Tra le altre, secondo l’Organizzazione, occorre definire chiaramente i prodotti soggetti a imposta o sovvenzione, con particolare attenzione agli eventuali effetti di sostituzione. I consumatori, infatti, potrebbero rimpiazzare i prodotti colpiti da oneri fiscali con bibite e alimenti altrettanto, se non più, dannosi alla salute, con pari o addirittura maggiore contenuto di calorie. Inoltre, le tasse non devono discriminare prodotti esteri: pertanto, sono preferibili le accise perché tassano allo stesso modo i prodotti nazionali e importati.
Al riguardo, va tenuto presente che il diritto comunitario proibisce ogni forma di tassazione discriminatoria dei prodotti di origine straniera rispetto a quelli domestici, così come di ogni discriminazione tributaria interna, volta a tutelare direttamente determinate produzioni (art. 110 Tfue).
I dubbi sulla leva fiscale
Per attestare l’efficacia delle politiche fiscali nel condizionare i consumi alimentari, l’Oms espone gli impatti positivi sortiti da tali politiche in una serie di stati.
Ma non tutti i casi depongono a favore di tale efficacia. In Danimarca ad esempio, l’inasprimento dei tributi a carico di taluni prodotti alimentari di largo consumo (come cioccolata, gelati, bibite gassate, alcolici), sperimentato da diversi anni, non ha prodotto gli effetti auspicati: da un lato, l’indice di massa corporea della popolazione è rimasto pressoché invariato; dall’altro, l’incremento del prezzo di vendita, conseguente alla maggiore onerosità della misura fiscale, ha generato la crisi di filiere produttive basate sui prodotti tassati. Peraltro, si è verificato che i cittadini si recassero oltreconfine per acquistare a prezzi più bassi generi alimentari analoghi a quelli tassati, e quindi più costosi, nel proprio paese. Pertanto, l’imposizione fiscale, piuttosto che mutare le abitudini alimentari della popolazione, ha favorito il commercio transfrontaliero, a beneficio degli esercenti dei paesi confinanti, e danneggiato le attività economiche locali.
Gli stati possono legittimamente utilizzare la leva fiscale nell’ambito delle proprie politiche volte a perseguire la salute collettiva. Tuttavia, al di là dei dibattuti effetti derivanti dall’uso di tale strumento, si pongono diversi dubbi circa l’opportunità dell’azione dello stato per influenzare i consumi alimentari dei cittadini.
Innanzitutto, lascia perplessi un intervento finalizzato a limitare comportamenti individuali – il consumo di alimenti non sani – che non hanno conseguenze nocive per i terzi, così violando il fondamentale “principio del danno”, di tradizione liberale. Si potrebbe sostenere che certe imposizioni normative mirino a tutelare il sistema sanitario nazionale, cui spetta prendersi carico di chi si alimenta male e, quindi, è più soggetto a certe patologie che è costoso curare.
Tuttavia, il nesso causale tra consumo di certi alimenti e patologie non è così certo: chi si nutre con cibi grassi o bibite zuccherate potrebbe non incorrere in alcuna malattia tra quelle che si reputano collegate a tali alimenti – ad esempio, qualora non avesse comorbilità o adottasse precauzioni compensative – ma sarebbe penalizzato comunque dal maggiore costo derivante dall’imposizione fiscale. Infatti, la tassazione di alimenti considerati dannosi colpisce chi li consuma a prescindere dal concreto impatto che essi hanno sulla sua salute, e ciò rappresenta una palese iniquità.
Inoltre, il condizionamento delle abitudini nutrizionali dei cittadini da parte dello stato si traduce in un giudizio indebito sulle condotte delle persone. Peraltro, anche stili di vita considerati più virtuosi – basti pensare agli incidenti che capitano a chi fa sport, pure in modo amatoriale – possono comunque comportare rischi per la salute per chi li pratica.
Consumi consapevoli
Per determinare consumi alimentari più consapevoli e sani può essere maggiormente efficace un approccio basato su una serie di interventi combinati, finalizzati alla massima trasparenza delle caratteristiche e dell’impatto sulla salute di cibi e bevande.
Persegue quest’obiettivo l’obbligo, imposto nel 2011 dall’Unione europea (regolamento n. 1169/2011), di etichette di generi alimentari preimballati che informino i consumatori in merito al loro apporto energetico e nutrizionale (come quantità di grassi, carboidrati, proteine ecc.). Ed è allo studio dell’Unione un’etichetta ulteriore, con informazioni nutrizionali aggiuntive, nella parte anteriore dell’imballaggio, per aiutare i consumatori a giudicare a colpo d’occhio le più rilevanti caratteristiche degli alimenti al momento dell’acquisto.
Sono poi necessarie campagne di comunicazione, sensibilizzazione, informazione sanitaria e alimentare tese a consentire scelte di acquisto e di consumo quanto più consapevoli. Quindi, interventi non coercitivi, ma rispettosi della facoltà di discernimento di ciascun individuo e mirati a fornirgli la cultura necessaria ad assumere le decisioni migliori per la propria salute. Lo sviluppo di una coscienza alimentare generalizzata determinerebbe l’aumento della domanda di alimenti salutari da parte del pubblico, e ciò potrebbe generare un circolo “virtuoso”. Siccome le imprese adeguano le proprie produzioni alla domanda dei consumatori, si avrebbe un’accelerazione della ideazione, produzione e vendita di prodotti più sani: dalle bevande a basso contenuto di zuccheri ai cibi con un limitato tenore di grassi agli alimenti con un elevato contenuto di fibre o di ingredienti naturali.
Insomma, politiche di educazione nutrizionale potrebbero risultare più incisive di un’imposizione fiscale per scoraggiare il consumo di prodotti dannosi, e così giovare alla salute e realizzare al contempo un contenimento nella spesa sanitaria.
Infine, quando qualcuno propone di incrementare le tasse per disincentivare i consumi di junk food servirebbe chiedersi se oggi sia sostenibile un aumento della pressione fiscale, che è a livelli ormai insopportabili in Italia, e se ciò sia sufficiente per conseguire gli effetti voluti. Soprattutto, occorrerebbe sempre mettere a confronto diverse opzioni di intervento, per valutare quali siano quelle che consentono di ottenere i maggiori benefici con i costi minori. Purtroppo, com’è noto, la cultura dell’analisi e della verifica di impatto non appartiene ai nostri decisori pubblici.
© Riproduzione riservata